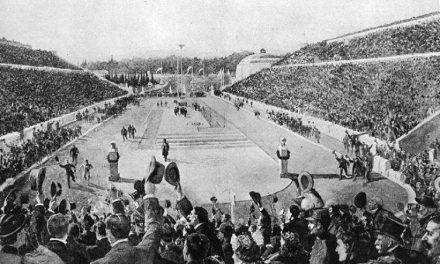La maratona delle donne: sesta e ultima puntata
La scozzese Dale Greig, nel corso della sua vita, non si è mai narrata come una pioniera della corsa su lunghe distanze o come «una campionessa dei diritti delle donne». Era solita dire che correva perché le piaceva «stare all’aria aperta»1. Per portare a termine la maratona dell’Isola di Wight del 1964, la fortuna di trovare organizzatori accondiscendenti e l’audacia di voler domare i 42195 metri d’ordinanza le erano bastate.
Anche Kathrine Switzer racconta che non si iscrisse alla gara di Boston nel 1967 per provare qualcosa a chissà chi: era solo «una ragazzina che voleva correre la sua prima maratona»2. L’allenamento non le mancava e poi, in fondo, una donna l’aveva già portata a termine prima di lei. Quindi, cosa c’era da dimostrare?
Eppure, a differenza di Greig, Switzer si rese conto ben presto che in ballo c’era molto più del sogno di una ragazzina. Persino la stampa, che diffondendo le foto dell’assalto di John Semple avrebbe comunque contribuito a ingigantire la portata del suo gesto, si era rivelata ostile: alcuni giornalisti, appena dopo l’aggressione, le avevano chiesto se era tutta una messa in scena e quanti chilometri aveva intenzione di percorrere prima di ritirarsi, e altri, al traguardo, le avevano domandato quale motivo l’aveva spinta a correre e se era una suffragetta!
«Pensavo avessimo conquistato il diritto di voto nel 1920!», osserva Switzer con sarcasmo nel rievocare l’accaduto3. In realtà, la chiave per capire perché lei sarebbe diventata parte della storia della maratona, anzi dell’atletica femminile, mentre una Dale Greig no, sta proprio nel diverso approccio avuto nei confronti del contesto sociale e culturale che le circondava e che, di fatto, imponeva loro restrizioni: la scozzese non si interrogò sul perché in Gran Bretagna le ragazze non potessero partecipare a gare ufficiali che contemplavano distanze superiori alle tre miglia o, comunque, non pensò mai di mettere la sua esperienza a servizio di questa causa; invece, l’americana, quel giorno a Boston, realizzò che andavano cambiate le regole della Amateur Athletic Union (AAU), affinché nessuno potesse più dubitare delle capacità di resistenza alla fatica che avevano le donne, e che raccontare e rivendicare quanto da lei fatto nella città del Massachusetts non poteva che giovare a questa battaglia.
Ad ogni modo, quelli della Boston Athletic Association nel 1968 scrissero nero su bianco che le donne non potevano prendere parte alla competizione ufficiale, sperando così di mettere un freno alle velleità femminili. Due anni dopo, gli organizzatori della neonata maratona di New York andarono subito in direzione contraria e accettarono l’iscrizione di Nina Kuscsik, che, però, non riuscì a terminare la gara (e, così, la prima vincitrice -Beth Bonner- si ebbe solo nel 1971). Finalmente, nel 1972 la famigerata AAU fece cadere il bando alle partecipazioni femminili e anche Boston si dovette adeguare. Giusto per riprendere il confronto prima proposto, nel Regno Unito nel 1975 le autorità sportive discutevano ancora se era giusto o meno far partecipare donne a una competizione di 10 miglia…
I tempi erano, comunque, maturi per il passo decisivo. La IAAF, la federazione internazionale, introdusse la maratona femminile sin dal primo Mondiale di atletica (Helsinki, 1983), mentre il CIO diede il suo assenso per l’Olimpiade successiva: il programma ufficiale dei Giochi di Los Angeles non prevedeva per le donne salto triplo, lancio del martello e gare in pista che andassero oltre i 3000 metri, eppure il 5 agosto 1984 cinquanta atlete provenienti da tutto il mondo poterono sfidarsi sulla distanza dei 42195 metri! E non ci furono ripensamenti di sorta o discussioni sulle capacità di resistenza femminili neanche dopo il sofferto e drammatico arrivo della svizzera Gabriela Andersen-Schiess, che percorse ciondolante l’ultimo giro, rischiò più volte di cadere e si fece aiutare solo dopo il traguardo. Il tutto in mondovisione.
Switzer quel giorno era ai microfoni di una tv americana, a commentare il successo della sua connazionale Joan Benoit. La sua carriera da atleta era stata discreta: la vittoria più importante nel 1974, alla maratona di New York; la migliore prestazione cronometrica a Boston, nel 1975, quando era scesa sotto le tre ore ed era arrivata seconda. La sua carriera da “simbolo” era, invece, già a buon punto e avrebbe raggiunto l’apice nel 2017, quando, a cinquanta anni di distanza dalla sua prima storica partecipazione, l’ormai settantenne ragazza del Wisconsin avrebbe corso la maratona di Boston indossando lo storico pettorale 261, alla guida di un gruppo formato da altri 260 concorrenti.
Puntate precedenti: Il barone e il ruolo delle donne alle Olimpiadi, Marie-Louise Ledru, audace pedestre, Violet Piercy, la pioniera che non fu presa a esempio, Times are changing: gli anni ’60 e la maratona femminile, Un giorno, alla maratona di Boston